Lo chiamavano il Paolorossi Vicenza

Livorno - “Solo il Paolorossi Vicenza tiene il passo della Juve”. Il titolo suonava più o meno così e non ricordo il nome del giornale che lo pubblicò. Non ricordo l’articolo, solo il titolo. Magnifico. Perché in cinque o sei parole c’era tutto. Il Lanerossi Vicenza, matricola terribile che insidiava lo scudetto alla miliardaria Juventus, era lui, il suo bomber: Paolo Rossi, toscano di Prato.
Avevo quindici anni ed ogni cosa era magica. Seguivo il campionato e tutte le domeniche, con consuetudine quasi religiosa, aspettavo la sera per vedere i “riflessi filmati” delle gare di Serie A, come si diceva allora, per scoprire cosa aveva inventato nel pomeriggio quel centravanti dal fisico esile e dalla faccia da bravo ragazzo, con l’espressione un po’ così, che a suon di gol aveva trasformato il piccolo Lanerossi, intrigante per quella maglia a strisce verticali biancorosse che mi ricordava quella dei Ferrovieri di Livorno dove avevo giocato da bambino, in una superpotenza del calcio, il Paolorossi Vicenza appunto, che si permetteva di contendere lo scudetto alla Juve di Dino Zoff, Franco Causio, Beppe Furino, Roberto Bettega, colonne portanti di una Nazionale che era stata rinnovata prima da Fuffo Bernardini e poi da Enzo Bearzot.
Era il 1978. I mondiali d’Argentina, quell’estate, passarono in fretta con la vittoria dei padroni di casa ma anche con la consapevolezza che qualcosa di nuovo, di buono, forse di grande, stava per accadere nel calcio italiano. La Nazionale, ormai affidata al friulano Bearzot, giunse quarta mostrando un gioco spumeggiante ed innovativo. Inutile dire che della spedizione fece parte anche il centravanti pratese del Vicenza.
L’anno dopo, con il suo passaggio al Perugia, Rossi divenne l’idolo dei tifosi umbri, anche se rimase idealmente legato al club veneto per sempre, club che nel frattempo era tornato in B e che nel mio immaginario ritornò ad essere semplicemente il Lanerossi e non più il Paolorossi Vicenza. In Umbria, pur di averlo, inventarono uno stratagemma che, di fatto, aprì la strada alle sponsorizzazioni di maglia in Italia. Il Perugia, che era giunto secondo l’anno prima, era pronto a diventare la nuova big del calcio italiano. Eppure proprio nella stagione perugina, sul finire del campionato 1979-80, accadde il fatto che avrebbe potuto stroncargli la carriera e privare noi delle emozioni che in una calda estate spagnola, due anni dopo, ci avrebbe regalato. Accusato di aver truccato la partita tra Avellino e Perugia, dove tra l’altro firmò due gol, venne squalificato per due anni, perdendo così la possibilità di partecipare con la Nazionale azzurra al campionato d’Europa che si svolse proprio in Italia pochi mesi dopo.
Quando i Carabinieri, alle cinque del pomeriggio del 28 marzo 1980, domenica delle palme, si presentarono nei principali stadi per arrestare, sì arrestare, alcuni tra i più famosi calciatori del campionato italiano, fu uno choc collettivo. Per molti fu la dolorosa fine di una passione, la scoperta di un tradimento, la conferma di un tragico sospetto. Non si trattava di una singola partita truccata, come già era accaduto in passato, ma di un sistema che coinvolgeva mezza Serie A. Quella a cui si assisteva non era una competizione sportiva, ma una farsa. E in questa farsa, secondo l’accusa, era caduto anche l’enfant prodige del calcio italiano.
La Juventus, che da ragazzino lo aveva scartato per via di alcuni problemi fisici ma che negli anni di Vicenza lo aveva ammirato e temuto, nonostante la squalifica credette in lui. Non fu difficile, per il presidente Giampiero Boniperti, trovare l’accordo. Rossi si aggregò alla squadra juventina e quando la squalifica terminò, a fine aprile del 1982, fece in tempo a giocare le ultime tre gare di campionato realizzando anche una rete all’Udinese mettendo così la firma sul ventesimo titolo del club bianconero di Torino.
Leggevo i giornali e speravo, in quella tarda primavera del 1982. Speravo che Bearzot, il cittì, lo convocasse ai Mondiali di Spagna. Non era scontato. Non possono oggettivamente bastare tre partite per dimostrare che il peggio è passato. I soloni del calcio dicevano che Rossi non era pronto, non poteva essere pronto, perché la ruggine di due anni di squalifica non si cancellano con un gol all’Udinese. E lì per lì sembravano aver ragione. Come spesso accade, anche in quel caso, chi detratta passa in vantaggio e sbeffeggia, salvo poi essere rimontato e spesso sconfitto.
Sul campo di Vigo, nella Spagna occidentale a nord del Portogallo, dove l’Italia, sempre pareggiando, affrontò nell’ordine Polonia, Perù e Camerun centrando una sofferta qualificazione, Rossi non brillò. Gli strascichi della squalifica apparivano evidenti. Ma Bearzot, nonostante tutto, credette in lui. E ci credette fino ad imporre, dopo il deludente girone eliminatorio, il silenzio stampa. Era la prima volta che l’Italia del calcio non parlava ai giornalisti. Solo il portiere e capitano Zoff, ormai quarantenne, poteva farlo. Lui era il portavoce dell’Italia. E durante quel silenzio, lasciando fuori le critiche proprio a Rossi, ad Antonio Cabrini e in parte anche a Marco Tardelli, il “vecio” dette ancora fiducia al “goleador spuntato col nome da ragioniere”, come qualcuno disse, schierandolo nella sfida che gli azzurri si aggiudicarono contro l’Argentina di Diego Maradona nel primo match del gironcino di ferro, seconda fase del Mondiale, dove c’era anche il superfavorito Brasile. L’Argentina in quella partita fu piegata dai gol di Tardelli e Cabrini. Il che sembrò un buon auspicio, visto che le polemiche avevano coinvolto anche loro, ma Rossi era rimasto ancora a bocca asciutta.
Avevo diciannove anni e il futuro davanti. Il 5 luglio 1982, al bagno Nettuno di Viareggio, seduto in prima fila con i miei amici, accaldati ma emozionati dopo una giornata di mare, sole, scherzi, discorsi sui massimi sistemi e bischerate, entrai in campo anch’io con l’Italia che affrontava il Brasile. La sfida era proibitiva. La Nazionale verdeoro metteva in campo gente come Zico Coimbra, Paulo Roberto Falcao, Toninho Cerezo e Socrates de Olivera, solo per citare qualcuno a caso, per cui sembrava veramente impossibile che l’Italietta fatta con questi ragazzi dai nomi ordinari, che aveva sì ben giocato con l’Argentina ma che ancora doveva dimostrare tutto, potesse anche solo pensare di tenere testa ai maestri del calcio, che gli addetti lavori additavano come la più forte squadra di sempre, perfino più del Brasile del 1970 che aveva un certo Edson Arantes do Nascimento detto Pelé. Inoltre, a complicare le cose, c’era il fatto che, in virtù del regolamento del torneo che dava un giusto vantaggio a chi aveva fatto meglio nella prima fase, al Brasile sarebbe bastato un pareggio per accedere alle semifinali, dato che aveva anch’esso regolato l’Argentina.
Ma noi italiani siamo fatti così. Non ci piacciono le cose semplici. Non devi farci giocare contro il Lussemburgo o Malta, se vuoi il meglio, ma contro l’Argentina, la Germania, il Brasile e compagnia danzante. Lì vedi l’Italia. E’ sempre stato così e forse sarà sempre così.
Seduti davanti alla tivù, non ricordo più se a colori o in bianco e nero, mi pare in bianco e nero perché nello stabilimento balneare piazzarono un secondo televisore dato l’alto numero di utenti interessati al match, assistemmo al miracolo italiano. In quello stadio Sarrià di Barcellona zeppo come un uovo, bello come solo gli stadi degli anni Ottanta sapevano essere, pieno di gioia e colori che non facevamo fatica ad immaginare, vedemmo prendere forma, minuto dopo minuto, una squadra maestosa, immensa, perfetta. Vedemmo il signor Rossi da Prato, il ragazzo della porta accanto, non solo smaltire gli effetti della lunga squalifica ma diventare Pablito, il mattatore dell’incontro, il “pichichi” del Mundial. Uno, due, tre e il Brasile, come già era successo nel 1938 in Francia quando aveva dovuto cedere la prenotazione del treno da Marsiglia a Parigi dove l’Italia giocò e vinse al “suo posto”, beata supponenza carioca, la finale contro la Cecoslovacchia, il Brasile, dicevamo, dovette ancora una volta farsi da parte e cedere idealmente alla Nazionale di Bearzot il pullman per l’altro stadio di Barcellona, il Camp Nou, dove avrebbe giocato e vinto la semifinale contro la Polonia, ancora grazie a due reti di Pablito, ultimo passaggio prima di spalancare le braccia al cielo nell’indimenticabile notte di Madrid, 11 luglio 1982, quando ancora Rossi, poi Tardelli e infine Alex Altobelli, regalarono all’Italia la gioia più grande con il presidente degli italiani, Sandro Pertini, che al terzo gol si alza come un ragazzino e dice “non ci prendono più” e Nando Martellini che urla nel microfono “campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo...”.
Dopo la vittoria sul Brasile, storditi ma felici, con una bandiera gigantesca che solo l’incoscienza dell’età ci aveva fatto cucire prima, più storditi che felici a dire il vero, saltammo al volo su un camioncino all’aperto ed andammo a far rumore e ballare sotto l’albergo che a Forte dei Marmi ospitava le ballerine brasiliane dell’Oba Oba, povere ragazze, per finire a fare il bagno, rigorosamente vestiti, nella fontana del Forte. Tutti ci volevano, tutti ci acclamavano. Ma non era per noi, era per la bandiera. Il nostro gigantesco tricolore era il più grande di tutti. Uno spettacolo. Avere quel bandierone accanto impreziosiva chiunque, quella notte.
L’Italia impazzì ed impazzì anche sei giorni dopo quando la Nazionale sconfisse in finale la Germania. Chi non c’era non sa cosa si è perso. Nulla a che fare con la gioia, pure grande, del 2006 in Germania contro la Francia. Quella del 1982 fu più vera, genuina, incontenibile, forse perché il clima sociale in Italia era diverso, forse perché il calcio era un’altra cosa, forse per questi motivi assieme, o forse, più semplicemente, perché chi scrive all’epoca era più giovane e le cose vissute in gioventù hanno un sapore diverso. File impazzite di auto, motorini con bandiere, camion e furgoncini con striscioni, canti e balli, l’Italia la notte del Barnabeu letteralmente perse la testa dalla felicità. Paolo Rossi, uno di noi, dopo aver schiantato il Brasile e messo a posto la Polonia, sparò il primo letale colpo alla Germania di Karl Heinz Rummenigge. Quando l’arbitro Arnaldo César Coelho, ironia della sorte brasiliano, emise il triplice fischio trasformando lo stadio di Madrid, inquadrato dall’alto, in un gigantesco set illuminato dai flash delle macchine fotografiche, milioni di persone, ovunque in Italia e nel mondo, si riversarono nelle strade, inebriate di entusiasmo, quasi scioccate, sostituendo l’azzurro del cielo al verdeoro di una torcida che a livello planetario tutti si aspettavano e che invece un ragazzo di Santa Lucia sobborgo di Prato, cittadino onorario di Vicenza, aveva spento prima ancora che potesse esplodere.
Fu un dramma, quel giorno, in Brasile. Una ragazza di vent’anni si tolse addirittura la vita. Ci furono scontri e tumulti a Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte. Nel Parlamento brasiliano si sprecarono interrogazioni e richieste di spiegazioni e la stampa chiese la testa del commissario tecnico Tele Santana che difatti venne esonerato salvo poi essere reintegrato alla vigilia dei Mondiali del 1986 in Messico. A fare piangere il Brasile, per parafrasare il titolo della sua autobiografia, era stato lui, quel ragazzo italiano di provincia, pigmalione di sé stesso, detto anche il Paolorossi Vicenza.
Oggi che Paolo Rossi se n’è andato, che il suo dolce sorriso e l’accento toscano rimangono solo nelle registrazioni e nelle immagini di uno straordinario tempo che fu, mi piace pensare, anzi penso in modo convinto, che quel fenomenale Mundial del 1982, in cui fu il migliore di tutti, fu anche e soprattutto la sua personale rivalsa, la sua rivincita, il suo sapersi riappropriare della dignità che avevano tentato di togliergli. Solo la consapevolezza di essere dalla parte della ragione ti porta a fare le cose che lui fece in quella estate del 1982. Bearzot gli dette fiducia, lo rimotivò, poi il resto lo fece da sé, spinto dalla forza dei giusti. Si riprese il diritto a parlare, a non tenere la bocca cucita, perché nessuno poteva più dirgii niente. Se qualcosa c’era stato, in quel match tra Avellino e Perugia, lui era stato più vittima che artefice. Ma in Italia, si sa, spesso chi ha le vere responsabilità rimane impunito ed a pagare il conto, piuttosto, sono coloro che nei guai ci finiscono per caso e spesso senza dolo.
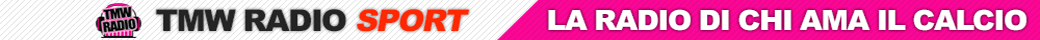










 Livorno – Nella domenica in cui il Tau Altopascio è l’unica tra le prime sei squadre della classifica a non centrare l’appuntamento con la vittoria (la Pianese surclassa il Sansepolcro con il risultato di 4 a 0; il Follonica Gavorrano si impone...
Livorno – Nella domenica in cui il Tau Altopascio è l’unica tra le prime sei squadre della classifica a non centrare l’appuntamento con la vittoria (la Pianese surclassa il Sansepolcro con il risultato di 4 a 0; il Follonica Gavorrano si impone...
 Livorno – In calce il link che conduce a Tmw Radio, l’emittente radiofonica on-line di Tuttomercatoweb.com.
Livorno – In calce il link che conduce a Tmw Radio, l’emittente radiofonica on-line di Tuttomercatoweb.com.
 La Spezia – Termina con il risultato di parità l’ultima partita della regular season tra la Fezzanese di mister Giulio Ponte e il Livorno di Matteo Brisciani: nonostante l’inferiorità numerica che ha lasciato gli amaranto in inferiorità...
La Spezia – Termina con il risultato di parità l’ultima partita della regular season tra la Fezzanese di mister Giulio Ponte e il Livorno di Matteo Brisciani: nonostante l’inferiorità numerica che ha lasciato gli amaranto in inferiorità...
 Livorno - L'Akern Libertas 1947 vince il derby con la Caffé Toscano Pielle in modo netto. Un derby caratterizzato da un forte agonismo da una parte, e da una squadra che di fatto, sembra non entrata in campo affatto, non onorando al meglio questo impegno. Di...
Livorno - L'Akern Libertas 1947 vince il derby con la Caffé Toscano Pielle in modo netto. Un derby caratterizzato da un forte agonismo da una parte, e da una squadra che di fatto, sembra non entrata in campo affatto, non onorando al meglio questo impegno. Di...
 Livorno - Un bel regalo di fine anno per la Libertas Livorno Unicusano. Sono state infatti ufficializzate le classifiche della Supercoppa di atletica leggera per l’anno 2023 da parte della Federazione di atletica leggera, classifica complessiva di tutti i campionati di...
Livorno - Un bel regalo di fine anno per la Libertas Livorno Unicusano. Sono state infatti ufficializzate le classifiche della Supercoppa di atletica leggera per l’anno 2023 da parte della Federazione di atletica leggera, classifica complessiva di tutti i campionati di...
